Partiamo da lontano. Quanti anni fa è avvenuto il primo incontro con la lingua persiana e in che occasione?
Poco più di undici. Era la fine del 2010 e stavo scrivendo la mia tesi di laurea. Avevo cominciato, decisamente in ritardo, a chiedermi come avrei potuto ‘reinventarmi’ con una laurea in Lettere. Beninteso: sapevo fin dal momento in cui mi sono immatricolato che con quegli studi le porte del lavoro non mi si sarebbero spalancate dinnanzi, ma le materie che suscitavano in me interesse, il cinema e il teatro, non offrivano né grandi appigli accademici né prospettive di lavoro più sicure, quindi avevo deciso di iscrivermi a una facoltà ‘canonica’ – una di quelle che, per intenderci, suonava familiare ai nonni e ti inseriva automaticamente nel novero delle persone serie – e di pormi solo in seguito il problema del ‘dopo’.
Alla fine del 2010, compiuti i venticinque anni, quel ‘dopo’ era alle
porte. Il primo pensiero fu di riciclarmi come giornalista, di seguire le orme paterne.
Dovevo però individuare un campo d’interesse, così da capire che binario infilare. L’arabo, con quella sua grafia misteriosa e quel sapore ‘lontano’, lo corteggiavo idealmente da parecchio. Giornalista di Esteri sia, mi dissi. Mi iscrissi come corso singolo alla prima annualità di lingua araba della mia università, la Statale di Milano. Ad aggiungere del sano ‘pepe’ a quest’esperienza avrebbe contribuito il fermento politico-culturale che di lì a pochissimo avrebbe preso piede: alla fine del 2010, l’ambulante Mohamed Bouazizi si sarebbe dato fuoco, dando dapprima il via alla rivoluzione tunisina e poi, tra le tante, a quella egiziana e siriana.
Interessantissimo, pensai tra me e me, sarò testimone di un evento epocale e avrò la possibilità di seguirne gli sviluppi confrontandomi direttamente
coi giovani di seconda generazione iscritti al corso. Nulla di meno vero, e non ci misi nemmeno molto a rendermene conto. Il dibattito universitario era monopolizzato da gruppuscoli più o meno riconducibili alla Fratellanza Musulmana, quando non addirittura salafiti. “Democrazia”, “libertà d’espressione” e “libertà religiosa”, parole con cui questi soggetti non perdevano occasione di riempirsi la bocca, corrispondevano solo in
apparenza a quanto intendevo io. Di fatto, alle dittature che osteggiavano quegli attivisti opponevano una visione altrettanto liberticida. Gli studenti italiani di sinistra, come me, vivevano visibilmente uno shock. C’erano due strade: tacere e tenersi quello shock per sé nel tentativo assolutamente vano di venirne a capo da soli o tentare di confrontarsi così da raggiungere un punto comune. Io optai per questa seconda strada, ma non andai
lontano: mettere rispettosamente in discussione quella Weltanschauung ti faceva finire dritto nella lista dei nemici. Quando dico ‘nemici’, intendo questo termine nella più ostile delle sue accezioni.
La tensione divenne via via sempre più palpabile, fino a quando decisi
che non ne potevo più. Terminai quell’annualità con un 30, tante amicizie troncate e un grande rigetto per quel mondo. L’errore fu anche mio, perché abbandonai un universo culturale ricchissimo al primo ostacolo, convinto che non avrei trovato altro che quel tipo di conoscenze.
Solo recentemente, e con grande fatica, mi sono riappacificato col mondo
arabo grazie ad alcuni amici straordinari e alla letteratura.
Come arriviamo al persiano?
Contestualmente, neanche a farlo apposta, conobbi una studentessa shiraziana residente a Firenze. Nacquero una bella amicizia e una frequentazione sempre più assidua che mi fecero intravedere il mondo degli studenti iraniani di stanza a Firenze. Inutile dirlo: rispetto agli studenti arabi di seconda generazione, c’era una differenza pari a quella tra il giorno e la notte. Poi, come nella migliore tradizione romanzesca, quell’amicizia si tramutò progressivamente in un amore importante, almeno da parte mia (ricordo ancora, però, promesse che mi fecero vibrare il cuore), e… e nulla, lei era già impegnata e decise, com’era giusto che fosse, di restare col suo compagno. Avevo un’età in cui potevo ancora permettermi di studiare un annetto, ero un romantico incallito e ormai un piede in Medio Oriente, almeno idealmente, lo avevo già messo.
Vado in Iran a studiare il persiano, mi dissi, giusto il tempo perché lei capisca che la amo davvero (perché, mi chiedevo io, quanto vuoi mai che ci metta a capitolare?) e intanto mi piglio un A1 o un A2 certificato dall’Università di Tehran. Fu così che nei primi mesi del 2013 vendetti la mia adorata Panda, tirai su qualche soldo e, sbrigate le pratiche con l’Università di Tehran e il consolato iraniano in Italia, ottenni il mio visto studentesco. Finì che io rimasi in Iran fino all’ottenimento del C2 (maggio 2014) e che lei si sposò con un altro. Il miglior finale, mi dico oggi. Era (o non era, a seconda di quello che intendiamo) qesmat (destino). Lei era inconsapevolmente entrata nella mia vita per mostrarmi un altro percorso, in un momento in cui vagavo senza meta, e una volta adempiuto al suo compito aveva deciso di uscire di scena. Ci sentiamo ancora, abbastanza di rado, ma non ci siamo mai rivisti. Forse è giusto così.
Quanto è cambiato il tuo rapporto con questa lingua da allora?
Molto. All’inizio si trattava di un amore dettato dal desiderio di conoscenza, dalla sfida per il possesso di un codice riservato a pochi, dal brivido provocato dallo stupore dei locali alla scoperta che parlavo la loro lingua pur non avendo origini iraniane. Tutte queste cose, col tempo, passano. E a quel punto siete solo tu e una lingua che ormai è a tutti gli effetti tua a fare i conti l’uno con l’altra. I casi sono due: o ti stufi e passi ad altro oppure la ‘accogli’ e la coltivi.
Come tratto questa lingua oggi? Le tributo il rispetto che merita, cercando di migliorarla giorno dopo giorno, ‘piallandola’ e usandola per fare qualcosa di utile in un campo comune: quello dello scambio culturale. Cerco di essere, allo stesso tempo, filtro e decodificatore. In questo senso, non si è mai – o non ci si sente mai – bravi e preparati a sufficienza. Si possono quindi aggiungere tasselli all’infinito, evitando sia la noia che la sensazione di essere ‘abbastanza’. È frustrante, ma anche rassicurante.
Il lavoro di traduzione è iniziato come un gioco per capire successivamente che questa sarebbe stata la tua strada oppure era questo che volevi fare con la lingua persiana?
Nessuna delle due cose. Una volta tornato in Italia ho iniziato quasi subito a fare dei lavori di traduzione, ma mi sono subito reso conto che i soldi che si guadagnavano erano pochi e saltuari e che se l’idea era quella di raggiungere un livello accettabile di sussistenza avrei dovuto pensare a qualcosa di più stabile. Salvo qualche sporadica parentesi, fino al 2017 la traduzione ha ricoperto un ruolo marginale nella mia vita.
Qual è stata la tua prima pubblicazione da traduttore? È un lavoro che ti è stato proposto oppure ti sei lanciato tu in quella sfida?
Ho avuto la fortuna di firmare la mia prima pubblicazione per la rivista italiana di geopolitica Limes, nel giugno del 2015, sul numero intitolato La radice quadrata del caos. Nello specifico, si trattava di un discorso di Ali Khamenei. Il lavoro mi era stato commissionato direttamente dal direttore Lucio Caracciolo, una persona di una cortesia e di una disponibilità uniche (ci tengo a dirlo perché i ‘Signori’ con la ‘s’ maiuscola sono merce rara oggigiorno). Caracciolo ovviamente non poteva conoscere quel preciso discorso di Khamenei: mi chiese di ricercare un’apparizione pubblica in cui venissero toccati alcuni precisi temi di interesse geopolitico, il rapporto con gli USA e la questione yemenita in primis. Feci una ricerca sulle fonti ufficiali e quel particolare discorso mi parve calzante. A Limes piacque e da allora collaboro stabilmente con loro in qualità di consigliere e di traduttore su questioni legate all’Iran.
Con il mio primo libro, Viaggio in direzione 270°, la questione fu completamente diversa. Avevo letto di quel libro in un bel manuale sulla storia contemporanea dell’Iran – Revolutionary Iran di Michael Axworthy – e lo avevo comprato e divorato nell’estate del 2015. Il tema della Guerra Iran-Iraq mi aveva sempre attirato. Mi affascinava e allo stesso tempo disgustava come quello che è stato il peggior conflitto della Storia del Medio Oriente, spia di un colonialismo arabo per nulla sopito (d’altronde, lo ha ricordato recentemente anche Gilles Kepel, l’altro nome attribuito all’invasione irachena dell’Iran è “Qadisiyya di Saddam”, chiaro riferimento alla distruzione dell’Impero persiano operato dalle truppe del Califfo Omar nel 636), potesse essere stato messo così frettolosamente sotto il tappeto sia dall’Occidente che dal mondo arabo: il primo, generoso fornitore di armi all’Iraq di Saddam Hussein in funzione anti-iraniana; il secondo, solerte accusatore delle invasioni e dei colonialismi ‘altri’ ma curiosamente più sonnecchiante, quando non giustificazionista e assolutorio, se a perpetrarli è lui stesso. Lo sguardo umano contenuto nel libro mi colpì come un cazzotto nello stomaco e mi convinse che non mi trovavo di fronte a un mero, preziosissimo documento storico (l’autore Ahmad Dehqan, mio amico fraterno, ha servito come basiji al fronte per sei anni): quel romanzo parlava una lingua universale e ci raccontava la medesima, antichissima tragedia – una tragedia che noi abbiamo imparato a conoscere solo da lontano, al liceo, nelle pagine di Hemingway o Lussu – che ha colto in gioventù anche i nostri nonni.
La letteratura di guerra, che mai come ora andrebbe riscoperta, ha l’incredibile capacità di abbattere i confini. Non conta l’ideologia, la lingua che parli o la religione che professi: alla mercé del fuoco incrociato, proverai quello che prova il tuo nemico. Le certezze incrollabili crollano e tu non capisci più che ci stai a fare lì, a chi spari, perché spari. Ho tradotto quel romanzo pian piano, mentre lavoravo come impiegato fantozziano e sostenevo gli esami della magistrale dell’Università di Padova e di Ca’ Foscari. Quando poi il libro è uscito e quelle poche persone che di Iran ci capiscono davvero si sono complimentate per la qualità del lavoro e per il servizio ‘storico’ reso (poi, chi lo sa, magari facevano ta‘arof – facevano i complimenti), mi sono detto che, tutto sommato, un po’ di talento come traduttore di letteratura dovevo pur avercelo. E così sono andato avanti.
Parlando del tuo lavoro come interprete per EUAA (European Union Agency for Asylum), quanto incide la tua emotività nell’interpretare e rendere fedelmente i bisogni e i desideri delle persone che si affidano alla tua traduzione?
Non dovrebbe, ma inevitabilmente incide. I fattori sono molteplici e imprevedibili. Molto banalmente, se senti una storia che richiama un tuo dolore o un’esperienza anche solo lontanamente comune tenderai a lasciare spazio all’emotività. Si tende a pensare che l’interpretariato sia un lavoro in cui puoi lasciare a casa sia il cuore che la testa, perché in fondo il lavoro che fai è robotico, ma non è così. Se in un’intervista lasci spazio all’emotività e ti avvicini al richiedente asilo, vizi irrimediabilmente il risultato del tuo lavoro. Ti faccio un esempio: un richiedente asilo o una richiedente asilo fanno breccia nel tuo cuore, la storia che raccontano ti spezza, ma tu ti rendi conto che il modo in cui stanno rispondendo alle domande del case worker danneggia la loro richiesta. Gli iraniani, infatti, hanno un vero talento: se nella narrazione di una vicenda esistono degli elementi rilevanti, stai pur certo che quelli saranno gli ultimi che menzioneranno; per i 9/10 del loro tempo si concentreranno su dettagli di nessun conto, nel tentativo di apparire precisi (e dunque, nella loro ottica, sinceri), finendo per convincere il case worker dell’inconsistenza della loro richiesta d’asilo (nell’ottica di un funzionario, comprensibilmente, i dettagli centrali di una storia sono i primi a essere esposti). Lì che si fa? Il tuo ‘io solidale’ ti spinge ad aggiungere quelle due-tre formule che sai per certo andranno a vantaggio del richiedente asilo (e anche al tuo, visto che di solito questi casi ti tengono lì per ore o addirittura giorni interi), magari nemmeno cambiando la sostanza del discorso ma andando incontro alle aspettative del case worker. La cosa da fare, tuttavia, è rigettare totalmente questo primo pensiero, richiamare prepotentemente la mente e mantenere una rigorosa, filologica inflessibilità. Quello che senti, traduci. E tu devi giocare in sottrazione. Certo, non è tutto lingua: se ti rendi conto che nella comunicazione tra le due parti (che non si comprendono, anche se spesso paiono dimenticarlo) c’è un macigno culturale, il tuo compito è spiegare ciò che la lingua cela. Come fai, banalmente, a capire se a fronte di una richiesta o di un’offerta un richiedente asilo sta facendo ta’arof e in realtà intende altro? E come comportarsi coi tabù culturali? Ecco, lì un minuscolo margine d’intervento è possibile concederselo. Il cuore, però, no. Vizia il lavoro e ti fa tornare a casa ancora più provato.
Dal momento che questa tua attività di interpretariato si svolge anche all’estero, come a Cipro e in Belgio, immagino che la lingua di arrivo di queste traduzioni sia l’inglese. In questo modo, per te, il lavoro diventa ancora più complesso?
Si potrebbe pensare di sì, ma in realtà non è del tutto vero. Certo la lingua d’arrivo, in questo caso l’inglese, va padroneggiata. In genere però hai a che fare con conversazioni assolutamente quotidiane, con gente che racconta i propri problemi nella lingua di tutti i giorni. Solo se hai a che fare con persone che hanno avuto problemi legali dovrai padroneggiare un minimo il lessico giuridico. Un po’ di pratica, qualche settimana su un dizionario legale (io di solito ricorro ad abidic.com) e qualche serie tv ambientata in tribunale e il più è fatto. È comunque fondamentale rispettare l’impostazione per così dire ‘filologica’: se uno ti parla nella lingua di tutti i giorni, quello che dovrai fare è mantenere il registro, non alzarlo né abbassarlo.
Vuoi raccontare ai lettori di Negah la storia di un/una richiedente asilo che ti ha particolarmente colpito?
Non devo nemmeno pensarci troppo, quella storia me lo ricordo come se l’avessi appena sentita. Era una madre che raccontava una storia di violenza domestica allucinante ai danni del figlioletto di quattro-cinque anni. Lei era tornata a casa e si era trovata davanti il marito tossicodipendente mentre puniva il bambino, ‘reo’ di aver fatto cadere un telecomando: lo stava ustionando su una natica con un cucchiaio arroventato; meticolosamente, con placida indifferenza, mentre il piccolo urlava disperato. Ricordo che mi immaginai distintamente la scena e mi venne da vomitare. Se ne accorsero sia la case worker che la richiedente asilo. Mi fu imposta una pausa di qualche minuto perché avessi il tempo di metabolizzare la cosa. Niente: quell’immagine ce l’ho avuta davanti tutto il tempo. Ce l’ho davanti pure ora che ne parlo.
Riesci a mantenere un certo distacco professionale oppure ti immedesimi nelle storie di queste persone portandoti a casa un peso?
Cerco di non immedesimarmi, ma a volte si fa davvero fatica. Spesso si sentono storie che sanno di artefatto o che comunque recano con sé qualcosa di ‘calcato’. Lì è facile: ti racconti che probabilmente ti stanno mentendo e ti convinci che quello che riceverai non sarà del tutto genuino. Quando arriva un dettaglio crudo ti dici che devi accoglierlo con scetticismo, che in fondo quella storia non è credibile alla base, che ci sono troppi elementi che hai già ascoltato e tradotto in altre interviste, che… E lasci che sia il case worker ad esprimersi sulla credibilità della storia. Tu ti fai felicemente da parte e il peso lo eviti a piè pari. Anche perché una volta che ti capita tra capo e collo, quel peso, non c’è verso di lasciarlo al lavoro. Te lo porti a casa, ci trascorri il weekend insieme e fai pure in tempo a riportartelo in ufficio giusto in tempo per caricartene un altro.
L’anno scorso ti abbiamo coinvolto per la prima edizione del Workshop di Traduzione di Negah intitolato “Gli strumenti del traduttore” in cui ti sei occupato di fare una lezione sul sottotitolaggio cinematografico. Inoltre, visto che sei stato coinvolto nel sottotitolaggio del film Zalava, puoi dirci in quale veste ti senti più a tuo agio? Nei panni del traduttore letterario, dell’interprete o del traduttore cinematografico?
In realtà si tratta di tre possibilità diverse di fare lo stesso lavoro e di fare ‘palestra’ nella sperimentazione dei registri. In una scala di difficoltà discendente direi che non altererei il tuo ordine: il primo posto va al traduttore letterario, il secondo all’interprete e il terzo al traduttore cinematografico. Il lavoro di traduzione letteraria è il più difficile: ti confronti con tutti i registri, dal più ‘alto’ al più popolare, devi saper scrivere e devi metterti in testa che seguirai il tuo autore anche nella ‘pancia’; se quando fai l’interprete devi giocare in sottrazione, qui devi ‘mettere’: mettere quanto ritieni l’autore o l’autrice stia mettendo, non di più non di meno, stando attento a interpretare correttamente lo spirito di quanto scritto. Il mestiere dell’interprete, una volta ‘posseduta’ una lingua, non sarebbe così complesso se non entrassero in gioco il fattore tempo e lo stress: il tempo a tua disposizione è poco e dall’altra parte ci sono persone che sembra stiano lì ad aspettare solo un tuo scivolone; una sfumatura non completamente resa, un’incertezza lessicale (magari dovuta a una concessione del richiedente asilo a una parlata locale o a una cadenza ‘regionale’) e avrai qualche secondo di titubanza; è umano, ma c’è chi davvero non ti perdona nulla. Il traduttore cinematografico, dei tre, è il più semplice: troverai perlopiù dialoghi quotidiani, con quasi nessuna variazione di registro; è divertente, a tratti addirittura rilassante, ed è un’ottima palestra per i discorsi diretti dei romanzi; oltretutto, come spiegavo all’inizio, il cinema è un mio grande amore da sempre, quindi ho trovato il modo di mettere la mia competenza linguistica al servizio di un cinema, quello iraniano, che spesso tocca vette davvero elevate. Zalava (premio come Miglior Film alla Settimana Internazionale della Critica del Festival di Venezia) e il suo straordinario regista Arsalan Amiri mi hanno dato la preziosa possibilità di essere parte di una grande vittoria del cinema iraniano in Italia.
Qual è l’ultimo libro che hai tradotto? Ci puoi dare qualche anticipazione su lavori futuri?
Conto di consegnare il romanzo “I vicini [Hamsayeha]” di Ahmad Mahmud a stretto giro. Purtroppo, per la prima volta in vita mia, sono stato colto dal famigerato blocco del traduttore e per mesi sono stato costretto a lasciare il romanzo da parte nel timore di rovinarlo. Per quanto riguarda progetti più imminenti, è appena uscita la raccolta di racconti Il palazzo di mezzanotte [Emarat-e nimeh shab] per la collana “Incroci di civiltà” della casa editrice Cafoscarina. L’autrice è l’iraniana Sepideh Siyavashi e il lavoro di traduzione è stato curato a quattro mani da me e dal Prof. Simone Cristoforetti dell’Università Ca’ Foscari.
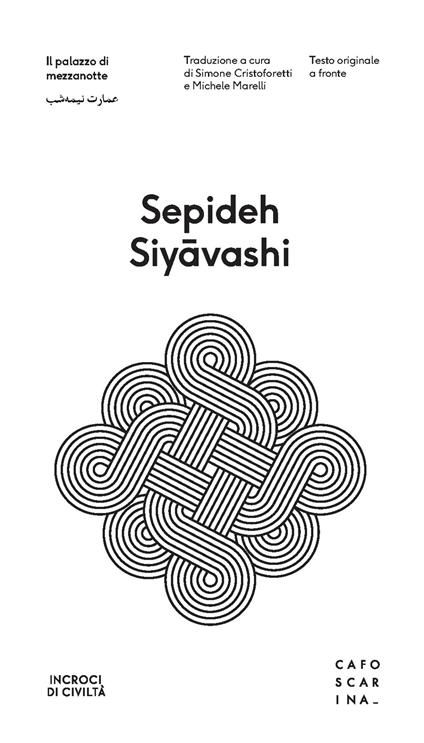
Segnatevi la data del 28 maggio: il festival “Incroci di civiltà” ospiterà (in presenza) Sepideh per una conversazione avente come tema proprio la raccolta di racconti in questione.
Non è la prima volta che “Incroci di civiltà” ospita un autore o un’autrice dall’Iran – Mostafa Ensafi e Mahsa Mohebali, per fare un paio di nomi eccellenti, hanno arricchito l’evento con la propria presenza e i propri interventi –, ma ora, per la prima volta, si ha un’opera iraniana pubblicata presso Cafoscarina (con testo originale a fronte) in rappresentanza dell’Iran. È stato un lavoro assai ‘sofferto’: doveva uscire due anni fa, era già tutto pronto (visto, biglietti aerei e hotel per l’autrice compresi) poi la pandemia ha costretto Ca’ Foscari a rinviare sine die la quindicesima edizione del festival. Disperavamo tutti. Poi, per fortuna, dopo due anni possiamo ufficialmente dirlo: “habemus Sepideh”. Un altro piccolo passo, si spera, per uno scambio culturale tra i nostri due meravigliosi Paesi.



Molto interessante!